|
Omelie
del tempo di Avvento 2020
a cura di
don Roberto Bischer
.
|
29.11.20
|
I
domenica di AVVENTO
|
B
2020
|

|
|
06.12.20
|
II
domenica di AVVENTO
|
B
2020
|

|
|
08.12.20
|
IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B.V. MARIA
|
B
2020
|

|
|
13.12.20
|
III
domenica di AVVENTO
|
B
2020
|
|
|
20.12.20
|
IV
domenica di AVVENTO
|
B
2020
|

|
...

I
domenica di Avvento – Anno B
(Is
63, 16b-17.19b; 64, 2-7; Sal 79; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37)
Campolongo,
29 novembre 2020
Fratelli
e sorelle, oggi iniziamo insieme il tempo di Avvento. Abbiamo acceso
la prima candela. In presbiterio, presso la barca, è stata posta
anche una lanterna: un ulteriore segno che può aiutarci a
percorrere questo nuovo tratto di strada nella fede, certi che il
Signore Gesù cammina con noi. Domandiamo fin d’ora al Signore di
vivere questo Avvento come un tempo di grazia, occasione propizia
per ciascuno di noi, per le nostre famiglie e comunità cristiane.
Invochiamo in modo particolare i doni della luce e della pace,
caratteristici dell’Avvento e del Natale.
Il
tempo di Avvento che oggi iniziamo si caratterizza inoltre per
alcuni cambiamenti liturgici determinati dalla terza edizione del
Messale Romano che, con questa domenica, iniziamo ad introdurre.
Come sappiamo, è la preghiera del Signore – il Padre Nostro – a
presentare alcune variazioni particolarmente significative. Perché
questi cambiamenti? Erano/sono necessari?
La liturgia della Parola di questa domenica potrebbe aiutarci
a soffermare la nostra attenzione su questo tema. Prendiamo in
considerazione la prima espressione della prima lettura (Is
63,16b17.19b; 64,2-7). Il profeta Isaia scrive parole molto belle:
“Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro
redentore” (Is 63,16b). Il tema della paternità ritorna anche
alla fine della stessa prima lettura: “Signore, tu sei nostro
padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo
opera delle tue mani” (Is 64,7).
Come
può Isaia scrivere espressioni come queste? Probabilmente perché
egli vive un rapporto particolarmente profondo con Dio; egli ha
fatto esperienza di Dio-Padre e ne ha parlato in quei termini. Anche
altri autori sacri hanno scritto della paternità divina;
evidentemente è Gesù Cristo che ha fatto conoscere con particolare
intensità il volto paterno di Dio (cfr. Gv 14,6-11).
Il
popolo di Israele ha assunto le espressioni di Isaia e, in modo più
ampio, i suoi testi all’interno degli scritti ispirati ossia di
quelli nei quali si è riconosciuta un’origine divina. Isaia ha
ascoltato una parola, ha fatto esperienza e l’ha trasmessa. Così
il popolo di Israele: ha ascoltato, ha fatto esperienza, l’ha
trasmesso. Anche la Chiesa ha fatto e fa tuttora la medesima
esperienza: riceve una testimonianza, ne fa esperienza diretta,
“mette-insieme” gli aspetti fondamentali della fede e li
trasmette nel tempo. Ricordiamo quanto definito dal Concilio
Vaticano II a questo riguardo, ossia delle due fonti della
Rivelazione di Dio: la Sacra Scrittura e la Tradizione della Chiesa
(cfr. Dei Verbum, nn.7-10). Non possiamo considerarle separatamente
o solo una delle due (cfr. i protestanti). Noi cattolici teniamo
insieme la Sacra Scrittura e la Tradizione della Chiesa che, alla
luce del Magistero, ci aiutano a custodire e a trasmettere il buon
deposito della fede.
Consideriamo
a questo riguardo le altre letture proclamate in questo giorno, in
modo particolare il vangelo (Mc 13, 33-37) e la seconda lettura (1
Cor 1, 3-9). Il vangelo di Marco ha presentato il tema della
vigilanza. La prima candela dell’avvento esprime esattamente
questo. Per descrivere l’esigenza alla vigilanza, Gesù usa
l’immagine di “un uomo, che è partito dopo aver lasciato la
propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo
compito” (Mc 13,34). San Paolo scrive con gioia alla comunità di
Corinto perché in essa “la testimonianza di Cristo si è
stabilita … così saldamente che non manca più alcun carisma”
(1Cor 1,6-7). Nella chiesa ci sono tanti carismi. E nella Chiesa il
processo di custodia e trasmissione della fede avviene tenendo conto
proprio di questo: ciascuno ha il suo compito, secondo lo specifico
carisma.
Forti
dunque di questo cammino personale e comunitario – che ci
comprende, ci precede e che segue – proseguiamo il nostro percorso
di Avvento, facendo nostra l’invocazione del salmo: “Fa
splendere il Tuo volto, Signore, e noi saremo salvi!”.
|
scarica
il file
|
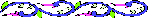
II
domenica di Avvento – B
(Is
40, 1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3, 8-14; Mc 1, 1-8)
Campolongo,
6 dicembre 2020
Fratelli
e sorelle, le letture proclamate in questa seconda domenica di
Avvento sono particolarmente ricche. Desidero proporre a voi un
possibile percorso che si concentra sulla necessità per l’uomo
– di per sé spesso richiamata – di fare memoria. A questo scopo
ricordiamo una attenzione da avere: per fare memoria occorre
ascoltare/meditare i testi sacri avendo presente il contesto più
ampio da cui sono estratti.
La
prima lettura (Is 40, 1-5.9-11) descrive una particolare fase di
passaggio del popolo di Israele. Sappiamo che si sta concludendo
l’esilio; Dio invia il profeta (il deutero-Isaia) ad annunciare al
popolo l’inizio di un tempo nuovo. Con il capitolo 40 del libro di
Isaia ha inizio il “libro della consolazione di Israele”
(proseguirà fino al capitolo 55). Il profeta Isaia, nella pagina
odierna, usa parole molto belle, piene di affetto e di consolazione.
“Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio
lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le
pecore madri” (Is 40,11). Il popolo di Israele sarà chiamato a
non dimenticare il tempo dell’esilio – con tutto ciò che l’ha
provocato – per poterne fare tesoro nel tempo del suo ritorno a
casa.
Anche
il salmo va considerato alla stessa maniera, nella sua interezza.
Oggi la liturgia ne ha proclamato solo l’ultima parte. Il salmo
completo è diviso in tre parti. Nella prima il salmista fa memoria
del passato, poi prosegue con l’invocazione sul presente ed infine
– ecco la parte odierna – preannuncia con gioia ciò che avverrà.
“Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal
cielo” (Sal 84,11-12). È una prospettiva che può essere rivolta
anche a noi oggi. È un richiamo volto a fare in modo che noi non
dimentichiamo da dove veniamo – chi è all’origine della nostra
esistenza – nonché verso dove stiamo andando. Siamo dunque
invitati a ricordare il passato, non stancarci di chiedere che il
Signore manifesti la sua grazia nel presente per poi attendere con
fiducia ciò che verrà (il ritorno a casa). La liturgia dunque ci
fa volgere lo sguardo alla vita eterna. In questi mesi, se ci
guardiano attorno, percepiamo paura, timore. La parola di Dio invece
ci ricorda che siamo chiamati a cantare ciò che verrà. Come
credenti dovremmo essere persone capaci di guardare al futuro, di
vedere ciò che viene dopo! Questo sguardo potrebbe aiutarci a far
tesoro di ciò che stiamo sperimentando in questi mesi segnati dalla
pandemia.
San
Pietro ci ha ricordato un tratto molto bello di Dio: “Egli invece
è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che
tutti abbiano modo di pentirsi” (2Pt 3,9). Il termine greco
utilizzato è metanoia: coincide con quanto dice oggi il Battista
nel vangelo. In questa domenica abbiamo ascoltato l’inizio del
vangelo di Marco (l’evangelista dell’anno liturgico in corso).
È un inizio che presenta fin dalle prime battute l’invito alla
conversione. Ricordiamo le prime parole di Gesù all’inizio della
sua vita pubblica: “Il tempo è compiuto, il regno di Dio è
vicino, convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1,15).
Dio
è magnanimo. Egli desidera che ci convertiamo di cuore per poter
essere salvati. Per aiutare la nostra conversione facciamo dunque
memoria di ciò che Dio ha fatto per noi. Egli non vuole che ci
perdiamo e per questo aspetta, con pazienza infinita, che ci
convertiamo. Il pentimento e la confessione sacramentale rientrano
in questo percorso. “Nel deserto preparate la via al Signore,
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia
innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno
accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata” (Is
40,3-4). Quelle valli, quei monti descritti da Isaia possono
esprimere gli aspetti e le situazioni che chiedono reale
conversione. Il Signore ci dona la possibilità di vivere delle
esperienze che chiamano a cambiare vita. A questo scopo siamo
invitati a “chiamare per nome” ciò che viviamo. Non si tratta
di un giudizio sulla persona, bensì di riconoscere con umiltà i
propri peccati per sperimentare concretamente la misericordia di Dio
ed essere aiutati a cambiare vita. Lo scopo del nostro Signore –
lo sappiamo – non è punirci, ma salvarci. Affidiamo dunque a Dio
con fiducia la nostra vita perché sia Lui a rinnovarla giorno dopo
giorno.
|
scarica
il file
|
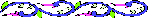
Immacolata
concezione di Maria
(Gn
3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)
Campolongo,
8 dicembre 2020
Fratelli
e sorelle, desidero condividere con voi alcuni pensieri sui quali ho
sostato in questi giorni in preparazione alla solennità
dell’Immacolata. Ho avuto modo di soffermarmi su alcune
riflessioni che don Fabio Rosini ha sviluppato su un antico inno
mariano: “Tota pulchra”. Mi pare che da questo canto, tramite
don Fabio, sia possibile esprimere contenuti molto belli e profondi
del mistero che stiamo celebrando.
“Tota
pulchra es, Maria”. Tutta bella sei Maria. Un’espressione
all’apparenza molto semplice. La bellezza di Maria è totale; non
ha zone d’ombra. Di per sé, anche il male ha una sua bellezza;
non possiamo negarlo; lo riconosciamo dal fatto che purtroppo
cadiamo facilmente nel peccato. La bellezza del male è tuttavia
parziale. Attrae all’inizio – ripensiamo alla prima lettura
odierna in cui viene narrato il peccato di Adamo ed Eva (Gn
3,9-15.20) – ma poi lascia tristezza, solitudine. Maria invece è
tutta bella! Lasciamoci attrarre dunque da Lei, fuggendo il male.
“Et
macula originalis non est in Te”. Anche noi siamo bellissimi,
tuttavia incompleti. C’è sempre qualcosa che ci disturba. A
differenza di Maria noi siamo feriti dal peccato. Di cosa si tratta?
Il termine greco che esprime il “peccato” indica la situazione
di chi fallisce il bersaglio. Avviene come alle automobili che hanno
una convergenza (delle ruote) non perfetta: quando si staccano le
mani dal volante la macchina tende a sbandare col rischio di finire
fuori strada o di invadere la corsia opposta. Con Maria non è così!
Con lei siamo chiamati a “centrare il bersaglio”: accogliere il
piano di Dio nella nostra vita; fidarci di Dio e guardare a lui.
Maria ha ricevuto una grazia speciale – essere immacolata fin
dall’inizio della propria esistenza – a motivo della missione
che Dio ha desiderato rivolgerle: accogliere Gesù nella sua carne.
La Chiesa non è moralista; Dio ha dato a Maria una grazia in vista
di una missione specifica; la sua accoglienza non è stata
“solo” il frutto delle sue capacità, ma anche di una grazia
specifica che ha preparato la sua missione; a questa missione poi
lei ha acconsentito. Abbiamo sentito il vangelo dell’annunciazione
(Lc 1,2638) in cui, alla fine, Maria dice: “avvenga per me secondo
la tua parola” (Lc 1,38). Ciascuno di noi hai una missione e una
grazia corrispondente per realizzarla, accogliendola con la propria
libertà.
“Tu
gloria Ierusalem”. Trattasi di un’espressione della Sacra
Scrittura. Sono parole che vengono rivolte a Giuditta, vittoriosa
contro il nemico Oloferne. Giuditta è una donna vedova, saggia,
sapiente e bella. Ella trova il modo per sconfiggere il nemico. Ella
dunque è la gloria di Gerusalemme perché è colei che dona alla
città la gloria. Giuditta libera Gerusalemme e, in tal modo, anche
tutto Israele. Giuditta rende libera la città santa. Queste
medesime parole sono ora rivolte a Maria: lei è la gloria del
genere umano. Ella ricorda “il peso” (la gloria) di ciascuno di
noi: il nostro valore è dato dall’essere figli di Dio. In Maria
il genere umano è glorificato. Maria ha mostrato che la nostra
carne può dire “sì” a Dio. “Caro capax salutis”, scrive
S.Ireneo di Lione: l’uomo è capace della salvezza (cfr. Ef
1,3-6.11-12). Anche in me può prendere carne il Figlio di Dio. La
Chiesa è la carne di Cristo. O Maria, fa’ che io oggi possa
diventare carne di Gesù.
“Tu
laetitia Israel”. Il termine letizia viene affiancato ad una
parola “particolare”. È un’associazione di significati da
comprendere adeguatamente. “Laetitia” può essere collegato a
“letame”. Il letame rende fecondo il terreno. Maria è colei che
ha reso fecondo Israele. Dio chiede anche a noi di essere fecondi.
Per fare questo abbiamo bisogno di lasciarci fecondare da Dio per
portare frutto secondo la misura di Cristo.
“Tu
honorificentia populi nostri”. L’espressione latina significa:
“Tu onore del nostro popolo”. Tu, Maria, hai ricordato ad ogni
uomo la possibilità di essere santo. Maria sottolinea l’onore di
ogni creatura. A volte perdiamo la bellezza e la nobiltà perché ci
trattiamo come fossimo “cose secondarie”. Capita infatti di
svendere la propria libertà, il proprio cuore … per avere chissà
che cosa? Invece siamo figli di Dio. Ecco perché a volte è bene
dire: “non ti far trattare così!”. Per te Cristo ha dato il suo
sangue! Recupera la tua dignità! Rialza il capo.
“Tu
advocata peccatorum”. Maria è “avvocata dei peccatori”. Mi
domando: quand’è che Maria opera in questo senso? Nel vangelo di
Giovanni, Maria agisce così in due occasioni: a Cana di Galilea (Gv
2,1-12) e poi ai piedi della croce (Gv 19,25-27). Nel primo episodio
ella si occupa della festa degli sposi; sotto la croce riceve da suo
Figlio il compito di essere madre di tutti noi.
Impariamo
da Maria, da ciò che ella dice alle nozze di Cana: “non hanno
vino” (Gv 2,3); Maria dice la verità: c’è un problema e lei lo
segnala con chiarezza. Poi però non si ferma qui; subito dopo offre
la soluzione sapiente: “qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv
2,5). Ecco Maria che conduce a Gesù.
“O
Maria, O Maria”. Il nome di Maria viene ripetuto due volte. Il
nome dice l’identità. È sempre importante saper dare nome alle
cose; esprime la “dimensione logica” (da custodire).
Il
nome di Maria contiene alcune “radici” significative. Richiama
innanzitutto il nome della sorella di Mosè; ci riferiamo dunque
all’acqua – al mare (“iam”) – da cui Mosè viene salvato.
Poi richiama la stella (“mar”). Maria è dunque la Maris-Stella,
la Stella del Mare. Quando ci si trova in mezzo al mare c’è
bisogno di un punto di riferimento (la stella del mare). Infine,
Maria è un nome che richiama l’amarezza; sebbene piena di gioia
(“l’anima mia magnifica il Signore …”; Lc 1,46) c’è un
problema di amarezza anche in Maria.
“Virgo
prudentissima. Mater clementissima”.
•
Virgo prudentissima: è un titolo che richiama la nota
parabola giovannea delle vergini che attendono lo sposo. Maria è
vergine ma non per questo inesperta, superficiale, banale; viceversa
è sapiente: conosce il fine delle cose, sa mirare allo scopo
finale, senza disperdersi.
•
Mater clementissima: Maria è madre ed è cle-mens:
inclina il capo, ha la mente che si flette, è condiscendente cioè
comprende chi ha davanti; in quanto madre, ella comprende. È capace
di adeguarsi a chi ha di fronte. Madre sa esser clemente; sa come
prenderti e portarti a Gesù.
“Ora
pro nobis. Intercede pro nobis. Ad Dominum Iesum Christum”. È la
richiesta di ogni “Ave Maria”: Santa Maria, Madre di Dio, prega
per noi peccatori. Abbiamo bisogno di qualcuno – di Maria – che
interceda per noi. Da soli non ci salviamo! Siamo “sulla stessa
barca”. Ricordiamo un
aspetto presente già nel “Confiteor”: “Confesso a Dio
onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato … e
supplico la Beata Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi
fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro”. È
un testo che esprime la necessità della preghiera reciproca per la
nostra salvezza: supplico … voi, fratelli e sorelle, di pregare
per me il Signore!
Dal
“Tota pulchra” impariamo dunque molto profondamente e con grande
amore a rivolgerci alla Vergine Santissima per seguire il Signore
nostro Gesù Cristo
|
scarica
il file
|
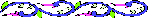
IV
domenica di Avvento – B
(2
Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16; Salmo 88; Rm 16, 25-27; Lc 1, 26-38)
Campolongo,
20 dicembre 2020
Fratelli
e sorelle, siamo giunti alla quarta domenica di avvento; il Natale
è oramai vicino. Sostiamo in preghiera in questi giorni con
fiduciosa attesa e rinnovato impegno affinché il Signore ci doni la
grazia di celebrare il Natale nella fede che tutto rinnova, quella
fede che porta luce e speranza nell’oscurità della vita e del
mondo.
Davanti
a noi, in questo giorno, vengono affiancati due grandi personaggi
delle Sacre Scritture, della storia della salvezza: il re Davide e
la Vergine Maria. La liturgia li affianca in due momenti precisi
della loro vita perché, distinguendone le rispettive
“sfumature”, possiamo cogliere quella parola (quel “colore”)
che Dio desidera donarci in questo momento.
Davide
e Maria sono stati scelti e chiamati da Dio per compiere una
missione specifica. Su di loro Dio ha posato il suo Spirito perché
essi potessero accogliere e vivere un progetto particolare, giorno
dopo giorno. Davide e Maria accolgono la chiamata di Dio e, per
questo, affrontano molte fatiche, molti nemici, molte difficoltà.
Il loro principale “campo di battaglia” non sembra essere
l’orizzonte di fondo prospettato dal Signore, ma le piccole scelte
e le singole situazioni quotidiane rispetto alle quali non è facile
decidere come comportarsi nella fede. Su questo “terreno
feriale” ho trovato particolarmente illuminanti alcune parole di
un biblista milanese, un frate cappuccino, Roberto Pasolini; le sue
riflessioni mi hanno aiutato ad approfondire questo aspetto.
Faccio
riferimento innanzitutto ad una sua citazione tratta da “Il
giovane Holden” (J.D. Salinger). Ci si domanda quale sia la
differenza tra un giovane e un adulto. Questa la risposta: il
giovane è disposto a morire per un ideale, l’uomo adulto è
disposto a vivere umilmente per esso. L’adulto vive giorno dopo
giorno per l’ideale che ha scelto, probabilmente con fatica ma con
determinazione. È una prospettiva che porta a dire che il mondo lo
si cambia riparandolo non facendolo da capo. E Maria Santissima ha
dimostrato questa fedeltà al quotidiano; la fedeltà di invocare
ogni giorno l’aiuto di Dio e di riscoprirlo presente. È
l’obbedienza della fede a cui siamo chiamati, come riporta anche
la conclusione della lettera di san Paolo ai Romani (cfr. Rm 16,27)
che oggi abbiamo ascoltato.
Pare
di poter dire che Davide sia caduto proprio sul “terreno
feriale” della vita. Dice il secondo libro di Samuele, nel testo
ascoltato nella prima lettura oggi (2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16), che
“il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici
all’intorno” (2Sam 7,1). È una frase che ha attirato la mia
attenzione. Da questa espressione possiamo comprendere che, grazie a
Dio, erano stati sconfitti tutti i nemici di Davide all’intorno;
restavano ancora però quelli all’interno. Occorre combattere sia
all’intorno che all’interno; la vigilanza va mantenuta su
entrambi i fronti; l’ascolto e l’obbedienza della fede vanno
coltivati con pazienza, fiducia e determinazione.
A
questo riguardo riporto, in conclusione, alcune parole di fra
Roberto Pasolini. Penso possano aiutarci a comprendere ulteriormente
quanto stiamo cercando di dire.
C’è
la difficoltà ad entrare in sinergia con la volontà
dell’Altissimo. È una grande tentazione, anzi, persino una
pericolosa mistificazione … rifiutare di confrontarsi con la Sua
sensibilità. Tocca a noi esprimere richieste e desideri. Purtroppo
le sofferenze della vita vorrebbero insegnarci che … non vale la
pena rivolgerci a Dio. Niente di questo appare nel cuore della
giovane vergine di Nazareth che non sembra aver alcun timore
nell’accogliere la parola di Dio con partecipazione e creatività.
Intuendo
che Dio aveva bisogno di Lei, del suo corpo, dei suoi giovani
affetti, della sua umanità al femminile, Maria non tace, ma
comunica con piena libertà il suo bisogno di essere illuminata per
poter aderire meglio al disegno di salvezza. La Vergine comprende
che l’avventura della vita conosce accelerazioni improvvise ed
invita a compiere passi enormi impossibili; per questo sente il
bisogno di assicurarsi soltanto di una cosa: che questo non sia un
sacrificio, ma un olocausto d’amore.
La
medesima parola udita da Maria, per altre vie ma con la stessa
intensità, bussa anche alla nostra porta, proprio in questi giorni.
A noi Dio rivolge l‘invito a essere un luogo santo dove la sua
parola di salvezza desidera ancora diventare storia sacra e nuova
umanità. Proprio noi che ancora una volta ci siamo incamminati (a
celebrare il mistero dell’Incarnazione) siamo chiamati a
convertire il cuore all’amore più grande, ad ascoltare il canto
dell’Annunciazione che comincia sempre allo stesso modo: con un
invito a riconoscere quanta benevolenza ha finora accompagnato la
storia della nostra vita.
Maria
si fa trovare; dice: “eccomi”, sono qui. Lo fa credendo che
mentre il cuore è ancora piena di paura la sua vita è piuttosto
colma di benedizione; che i motivi per sorridere sono infinitamente
maggiori di qualsiasi ragione per piangere o declinare l’invito
del cielo. Non ha paura di credere perché non ha esitato a
chiedere. Anche noi sapremo cambiare qualcosa della nostra vita e
del mondo solo se saremo disposti a dialogare con Dio, là dove
siamo ancora in attesa di comprendere in che modo la nostra
esistenza può diventare un dono d’amore.
|
scarica
il file
|
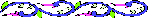
Santa
Famiglia 2020 – B
(Gn
15, 1-6; 21, 1-3; Salmo 104; Eb 11, 8.11-12.17-19; Lc 2,22-40)
Campolongo,
26-27 dicembre
Fratelli
e sorelle, le letture che quest’anno sono state proclamate nella
festa della Santa Famiglia mi hanno fatto pensare ad un tema che in
questi primi mesi del cammino pastorale comunitario stiamo
sviluppando nell’ambito del percorso di catechesi con le famiglie,
specificamente con gli adulti.
La
liturgia odierna si concentra in modo particolare sulle figure di
Abramo e Sara: sono loro i protagonisti principali della prima e
della seconda lettura ed è a loro che Dio indirizza la promessa di
una discendenza.
Nella
pagina di Genesi che abbiamo ascoltato (Gn 15, 1-6; 21, 1-3), Abramo
si rivolge al Signore con queste parole: “Signore Dio, che cosa mi
darai? Io me ne vado senza figli … A me non hai dato
discendenza” (Gen 15,2-3). Nella lettera agli Ebrei (Eb 11,
8.11-12.17-19) viene descritta la fede di Abramo e Sara in questi
termini: “per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì … e partì
senza sapere dove andava; per fede, anche Sara … ricevette la
possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui
che glielo aveva promesso” (Eb 11,8.11). In questa stessa fede il
salmo di oggi (Sal 104) ci ha esortato a rimanere, ripetendo più
volte nel canto il ritornello: “Il Signore è fedele al suo
patto”.
Il
tema della discendenza presentato ad Abramo e Sara riguarda per
certi aspetti anche il vangelo odierno (Lc 2,22-40). Il brano di San
Luca descrive la presentazione di un figlio, Gesù, da parte dei
genitori al Tempio di Gerusalemme: un fatto particolarmente denso di
significati che viene arricchito ulteriormente, come sappiamo, dalla
presenza di Simeone e Anna. La presentazione del bambino Gesù
esprime l’atto di obbedienza e di fede che Maria e Giuseppe
compiono verso Dio secondo i precetti religiosi del tempo. Questo
gesto può ricordare a noi un aspetto molto delicato, importante, da
comprendere in profondità: il fatto che il figlio (ogni figlio),
frutto dell’amore dei coniugi, appartiene a Dio, è a Lui
consacrato e da Lui riscattato.
Ripensando
da un lato alla figura di Abramo e Sara in rapporto alla loro
discendenza e, dall’altro, a Maria e Giuseppe nel momento della
presentazione di Gesù al Tempio, sono emerse alcune riflessioni che
mi sembra possano aiutarci ad approfondire un tema che in questi
mesi è emerso, come anticipato, nell’ambito degli incontri con i
genitori dei ragazzi del catechismo.
Con
i genitori stiamo sviluppando le caratteristiche della preghiera
cristiana. Tra i vari aspetti ci siamo soffermati sulla duplice
realtà che ciascuno di noi vive, seppur in modo diverso, quando si
pone in dialogo con Dio. La preghiera è precisamente questo:
dialogo con Dio. In questa relazione con Dio ciascuno di noi si può
percepire secondo una duplice prospettiva: come figlio e/o come
genitore (padre/madre). Evidentemente questa “condizione
generativa” va considerata non solo in senso biologico ma anche
spirituale.
Le
figure di Abramo e Sara, unite a quelle di Giuseppe e Maria, nelle
pagine oggi proclamate, possono aiutarci ad approfondire questo
tema, trovando ulteriore luce[1].
Soffermiamoci
sull’esperienza di Abramo, sulla sua relazione con Dio, così come
va maturando nel corso del tempo. Potremmo dire che Abramo viene
aiutato da Dio a vivere un particolare cammino esistenziale
(spirituale) di purificazione. Dio lo porta a considerare
(purificare) la sua duplice dimensione di figlio e di padre
all’interno della più ampia e profonda relazione con Dio stesso.
La
duplice relazione con il padre (Terach) e con il figlio della
promessa (Isacco) non va considerata prima di tutto in sé stessa,
ma in funzione del cammino spirituale di Abramo, della sua salvezza,
messa a repentaglio da alcune tentazioni (rischi) da cui il Signore
vuole preservarlo. Filo conduttore di questo cammino potrebbe essere
riconosciuto del duplice comando – “vattene!” – che, nelle
Sacre Scritture, Dio rivolge ad Abramo: “vattene dalla tua terra
… dalla casa di tuo padre” (Gen 12,1-2); “vattene verso la
terra di Moria… ” (Gen 22,2). Come intendere questi comandi,
cosa possono significare per noi, per la nostra relazione con Dio?
Dio
innanzitutto comanda ad Abramo di lasciare la casa di suo padre;
perché? Non si tratta evidentemente di considerare la casa paterna
– gli affetti, i legami di sangue – in senso negativo. Sappiamo
che una delle “Dieci Parole” che Dio comunica a Mosè dice
“onora il padre e la madre” (cfr. Es 20,12). Dunque per
comprendere in profondità tale comando dobbiamo ricordare la
particolare vicenda di Abramo. “La casa del padre” sta ad
indicare un legame “viziato” che può portare Abramo a chiudersi
in sé stesso, a ripiegare dentro le altrui bramosie. Pertanto
Abramo, per salvare la propria vita, deve lasciare “la casa
paterna”, deve uscire da un contesto pericoloso. Il comando non
intende far soffrire Abramo, bensì salvarlo; ancora una volta Dio
si dimostra estremamente paterno (Lui sì).
In
un secondo momento, Dio comanda ad Abramo di andare sul monte per
offrire un sacrificio (il figlio, la sua libertà?). Dio vede che
Abramo rischia di ricadere in quel pericolo da cui era a suo tempo
scampato abbandonando – come ordinato da Dio – la casa paterna.
In altre parole Abramo rischia di comportarsi come suo padre Terach.
Abramo si trova nella tentazione di vedere e intessere la relazione
con il figlio Isacco – il figlio della promessa – in modo
possessivo, egoistico, mortifero. Abramo deve “lasciare andare”
suo figlio, sciogliere i lacci con i quali tiene legato a sé il
figlio. Solo in questo modo potrà essere realmente padre,
generativo, quindi capostipite di una generazione immensa come le
stelle del cielo (generazione dentro la quale ci siamo anche noi
…).
Quale
messaggio può venire a noi da tutto questo? Anch’io, in quanto
figlio/padre, posso essere chiamato da Dio a lasciare tutto ciò che
impedisce di essere generativo: verso la “casa paterna”, verso
“i miei figli” (le giovani generazioni). Questo perché genitori
e figli (giovani generazioni) oltre che un dono sono, ben più
profondamente, un segno che Dio mi offre per crescere nella
relazione con Lui e, fondamentalmente, poter essere salvato ossia
entrare in possesso della terra promessa, la vita eterna. Come
padre/madre o educatore devo saper far di tutto perché i figli (le
giovani generazioni) che mi vengono affidati (per un certo tempo),
possano essere in grado di “stare in piedi” con le loro gambe,
ossia instaurare e far maturare in loro una profonda relazione con
Dio in modo che anch’essi possano essere a loro volta realmente
generativi.
Ecco
dunque il messaggio per ciascuno di noi: coltivare (in sé e negli
altri) relazioni generative, capaci di generare vita.
Maria e Giuseppe dimostrano questa capacità, nel brano
ascoltato oggi e in tutte le altre situazioni narrate nelle Sacre
Scritture. Alla stessa maniera anche Simeone ed Anna: sono capaci di
attendere la venuta del Redentore, servendo Dio notte e giorno nel
Tempio così che, una volta incontrato, possono trattenerlo con
gioia, anche solo per un istante, tra le braccia.
|
scarica
il file
|
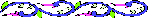
|